


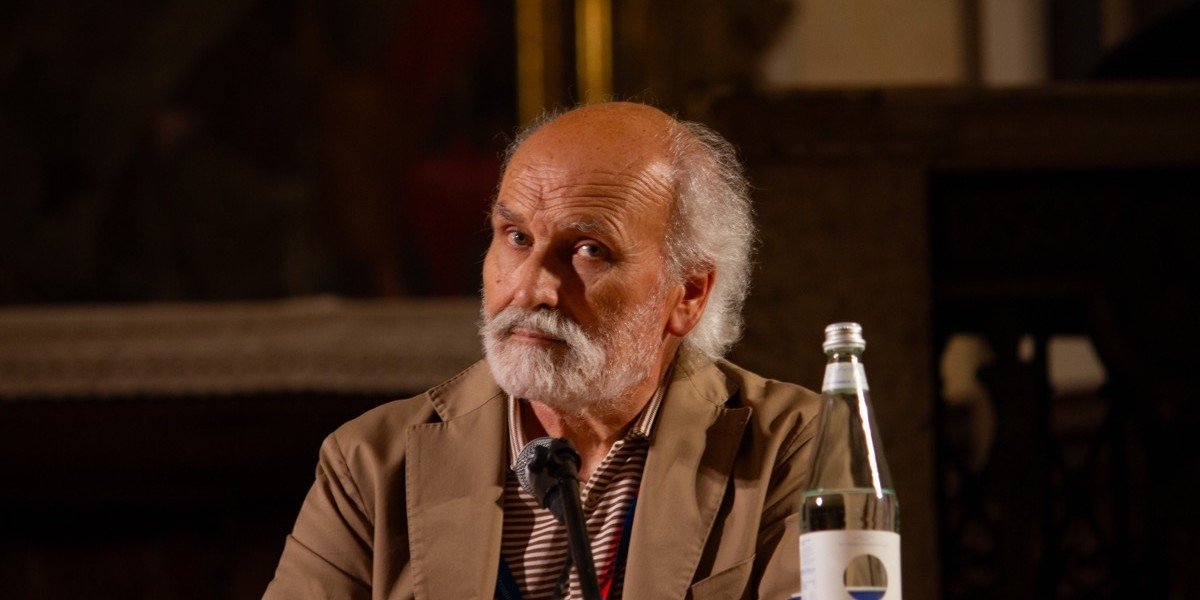
Navigare nei sogni: il mestiere dell’onironauta
Si dice che siamo fatti circa per il 60% di acqua. Probabilmente, il restante 40% è fantasia, altrimenti non si spiegherebbe il continuo bisogno dell’essere umano di evadere dalla vita quotidiana tramite musica, libri, film, sogni. Cerchiamo mondi paralleli ogni giorno, più volte al giorno, soprattutto nel momento in cui le nostre inibizioni si dissipano: la notte. I sogni ci permettono di riorganizzare le esperienze vissute durante la giornata, offrendoci nel contempo un intrattenimento per nulla scontato. Nella maggior parte delle volte, assistiamo passivamente allo spettacolo, ma può capitare di rendersi conto di essere all’interno di un sogno e addirittura di cambiarne il canovaccio. Chi ha successo in questa impresa è conosciuto come “onironauta”.
Fino agli anni ’80 non si riteneva possibile una piena consapevolezza in queste situazioni: è stato solo grazie agli studi di Stephen LaBerge che il fenomeno dei sogni lucidi ha iniziato ad essere approfondito. Durante il sonno REM (che si verifica tre o quattro volte per notte) tutti i muscoli del corpo sono immobilizzati, a eccezione dei bulbi oculari, che si muovono velocemente simulando interazioni con il mondo esterno. In questa fase hanno luogo i sogni, anche se spesso al risveglio non li ricordiamo. Ai più fortunati, può capitare di assumere coscienza e provare un'esperienza di veglia. Ecco allora che si approfitta della situazione per decidere di sistemare dei conti in sospeso, dare un bacio fedifrago o spiccare il volo dal punto più alto di una rupe.
Secondo le statistiche, è capitato di essere onironauta ad almeno una persona su due, come minimo una volta nella vita, mentre una persona su venti lo sperimenterebbe abbastanza spesso. Perché è una situazione che ci si augura di provare? La domanda di Ugo Morelli (saggista e psicologo) è quella che si pongono in tanti, e la risposta di Francesco Tormen (docente di lingua e letteratura tibetana a Ca' Foscari, oltre che co-direttore del Centro Studi dell'Unione Buddhista Italiana) non è per nulla scontata. Gli onironauti accedono a stati di sé che altrimenti rimarrebbero inesplorati. Sogno fa rima con fantasia, gioco, immaginazione. Essere consapevoli dei propri sogni significa ritrovare una connessione con la propria parte bambina. È tornare indietro nel tempo? No, in questo caso l’infanzia è da intendersi come uno stato della psiche, non uno stadio dell’esistenza.
Condizione simile è quella di coloro che si cimentano in esperienze extra-corporee poco prima dell’addormentamento, ponendosi nello stesso stato di coscienza degli onironauti. La tradizione buddista tibetana individua tre macro strati di quest’ultima, che portano alla consapevolezza della non dualità tra mente e corpo. Non siamo né pura coscienza, né pura esperienza. La meditazione, partendo dai sensi, ci guida verso i vari strati dell’interiorità, fino a giungere al cosiddetto ritorno a casa o estrema beatitudine. Più siamo coscienti di noi stessi, più lo saremo anche durante i sogni.
L'intervista di Ugo Morelli con la redazione di Festivaletteratura