


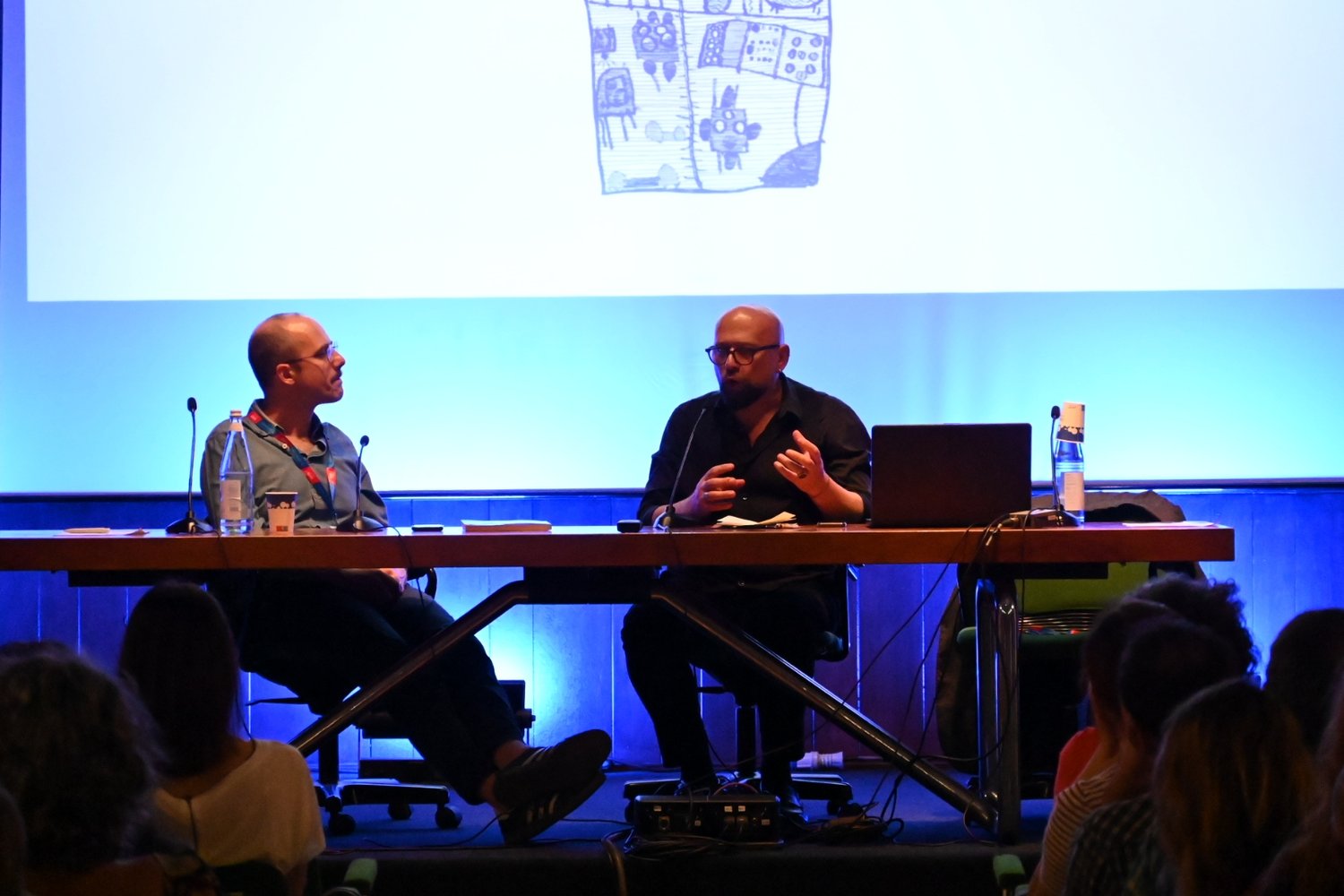
Una «controgeografia» del possibile
Quando pensiamo a una mappa ci immaginiamo di aprire l’applicazione di Google Maps sul cellulare e digitare nella barra di ricerca l'indirizzo esatto della nostra destinazione. L’utilizzo che ne facciamo è chiaro: una mappa ci indica il punto nello spazio in cui siamo e fornisce dei percorsi efficienti per raggiungere un altro punto. Precisione, è questo che vogliamo. Ma è l’unica cosa che possiamo pretendere dalle mappe?
Se guardiamo delle impronte di animali sul terreno, a descrivere percorsi che hanno battuto in varie direzioni, noi siamo di fronte a qualcosa che è molto concreto, perché la traccia lasciata è visibile, è tangibile; eppure, quello che le impronte fanno è alludere a qualcosa che non c’è più, a un animale passato da lì e non più presente in quel luogo, in quel momento. Allo stesso modo, le mappe, nel mostrarci le geografie, ci dicono che esiste una quota di invisibilità, una quota di elementi che mancano. E sta all’osservatore completarle inserendo ciò che in loro è assente.
Da una visione statica e bidimensionale delle mappe, che dalla cartografia cartacea è stata trasferita sui supporti digitali che usiamo quotidianamente, Matteo Meschiari nel suo Terre che non sono la mia. Una controgeografia in 111 mappe (Bollati Boringhieri, 2025) ci esorta a cambiare prospettiva. Ad esempio, siamo sicuri che una mappa possa essere orientata solo in direzione Nord-Sud? Cosa accadrebbe alla nostra percezione dello spazio se invece ruotassimo le cartine di 90°? La risposta è che con tutta probabilità non saremmo più in grado di orientarci e non sapremmo più dedurre dai margini delle terre emerse quale regione del mondo stiamo guardando. Eppure, a rifletterci bene, quella da noi adottata è una semplice convenzione, come lo è il porre l'Europa al centro delle carte geografiche, o disegnare il mondo a partire dalla terra, invece che dal mare.
Se si sposta il punto di vista e si immagina «il mondo visto da un pesce», la mappa che ne viene fuori è stranissima. Nel 1942 il geofisico Athelstan Frederick Spilhaus realizzò una mappa delle acque del pianeta, raffigurando gli oceani come pieni e le terre emerse come vuoti, e il risultato è una rappresentazione di quello che potrebbe essere un mondo di pura invenzione, come quelli creati da J. R. R. Tolkien ne Il Signore degli Anelli.
Le mappe possono occuparsi anche di qualcosa che vada ben oltre il piano della concretezza. Per molti popoli l’esattezza non era importante, per loro le mappe servivano per situarsi in un altrove, nell’aldilà. Gli sciamani, ad esempio, usavano le mappe celesti tracciate sui vestiti come ausilio per poter svolgere le loro pratiche divinatorie, alla ricerca di un contatto con le anime che erano state scacciate dal mondo dei vivi. O ancora, esistono testimonianze, quale il reperto archeologico della mappa di Bedolina in Val Camonica, di mappe che possono essere interpretate in diverse maniere: sotto una chiave di concretezza, come mappa catastale fatta di segni volti a indicare terreni, coltivazioni, animali, o sotto una chiave astratta, come mappa sciamanica.
La geografia che siamo abituati a consultare è una geografia del determinismo, in cui i territori sono stati mappati per fornire informazioni a scopo militare, per permettere agli eserciti di attaccare e soggiogare i popoli. A questa geografia del potere, Meschiari si ribella fornendo un'alternativa, una «controgeografia» che ci mostri ciò che va oltre la materia, che includa le emozioni, la memoria, il trauma, per poterci muovere in uno spazio fatto di possibilità. Meschiari ci ricorda che:
«noi mappiamo luoghi non solo per occuparli, ma per ribadire lo spirito di libertà».
 Qui trovate l'evento a cui ci riferiamo
Qui trovate l'evento a cui ci riferiamo